La rivoluzione dell’IA in medicina è già iniziata: diagnosi più rapide, predizione delle malattie e cure personalizzate. Ma servono regole e responsabilità.
Un tempo era un concetto da film di fantascienza. Oggi, l’intelligenza artificiale in medicina è una realtà in costante espansione. Dai sistemi diagnostici automatizzati agli algoritmi che prevedono le malattie prima che compaiano i sintomi, fino alla selezione dei trattamenti più efficaci per ogni paziente: l’IA sta trasformando il modo in cui si cura e si studia la salute.
Il merito va all’enorme quantità di dati sanitari oggi disponibili — strutturati e non — e alla potenza dei sistemi informatici che, grazie al machine learning, imparano dai dati stessi. Non si tratta più di semplici programmi che eseguono ordini: le macchine ora sono in grado di “ragionare” e suggerire soluzioni, offrendo supporto concreto al lavoro dei medici.
Diagnosi, predizione e trattamenti: dove l’IA fa la differenza
L’applicazione più consolidata è quella nella diagnostica. Sistemi intelligenti istruiti su migliaia di immagini mediche(radiografie, ecografie, TAC, ECG, esami istologici) sono in grado di identificare patologie tumorali, cardiovascolari, dermatologiche o polmonari con un livello di affidabilità sempre più elevato. In ambito oncologico, ad esempio, si stanno sperimentando strumenti che prevedono lo sviluppo di un tumore al polmone fino a sei anni prima, incrociando immagini radiologiche e dati clinici.
Un altro settore promettente è quello della predizione di patologie. Alcuni algoritmi, analizzando parametri vitali e precedenti clinici, riescono a intercettare segnali di rischio per malattie cardiovascolari come fibrillazione atriale o scompenso cardiaco, consentendo interventi preventivi mirati.
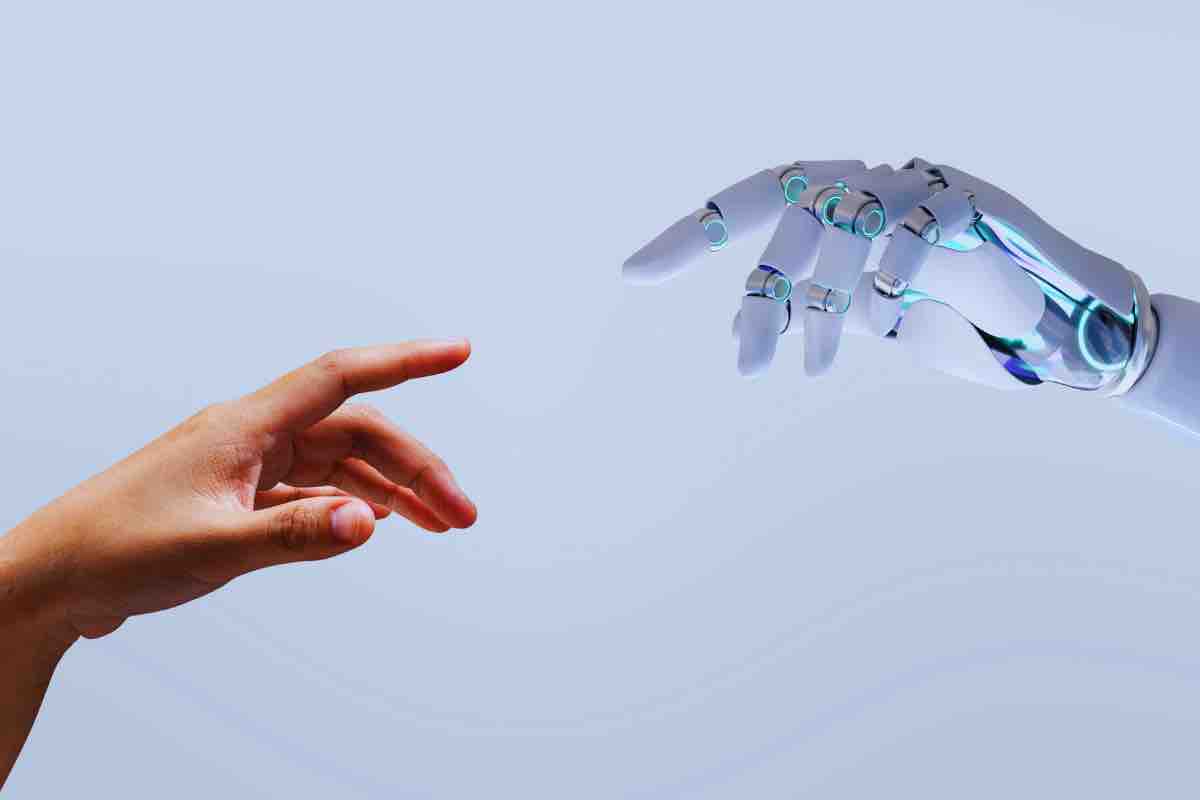
L’IA è utile anche nel supporto terapeutico: basandosi su linee guida, evidenze scientifiche, storie cliniche e decorso di pazienti simili, suggerisce opzioni di trattamento personalizzate, migliorando l’aderenza alle cure e riducendo l’errore umano. Inoltre, viene impiegata per accelerare la sperimentazione di nuove molecole attraverso l’analisi automatica di enormi librerie di composti, identificando le più promettenti da portare in clinica.
Negli Stati Uniti, oltre 500 applicazioni di IA in medicina sono già state approvate dalla FDA. In Italia, la maggior parte è ancora in fase di sperimentazione clinica, ma il potenziale è enorme.
I rischi da evitare: black box, bias e assenza di validazione
Tuttavia, l’impiego dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario non è privo di rischi. Il più grave è quello legato a sistemi non sufficientemente testati, privi di valutazioni cliniche solide e multicentriche, che potrebbero generare errori diagnostici o terapeutici.
Un altro problema riguarda i bias nei dati di addestramento: se il campione su cui l’IA viene istruita non è rappresentativo della popolazione reale, il sistema potrebbe fallire nel riconoscere patologie o situazioni specifiche, con conseguenze gravi. È ciò che accade, ad esempio, quando le minoranze etniche o i pazienti con comorbidità rare non sono inclusi nei dataset.
A questo si aggiunge il fenomeno della black box, ossia la difficoltà a comprendere come l’IA sia arrivata a una determinata decisione. In medicina, dove la trasparenza e la tracciabilità delle decisioni sono cruciali, si tratta di una questione etica e deontologica.
Per questi motivi, le nuove linee guida pubblicate dal Ministero della Salute, redatte anche da Eugenio Santoro, raccomandano studi prospettici, randomizzati e su larga scala, nonché regole più stringenti per l’approvazione di questi strumenti, in linea con il nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici.
Le applicazioni italiane: dal Mario Negri ai progetti europei
In Italia, uno dei poli più attivi nella ricerca sull’IA applicata alla medicina è l’Istituto Mario Negri, che sviluppa strumenti avanzati in collaborazione con istituzioni europee.
Il Laboratorio di Medical Imaging lavora sull’apprendimento profondo per la segmentazione automatica di organi e tessuti, fornendo misurazioni fondamentali per la diagnosi, soprattutto in ambito polmonare e renale. Un altro progetto riguarda la predizione della maturazione delle fistole arterovenose nei pazienti in dialisi, grazie ad algoritmi capaci di identificare in anticipo i casi destinati al successo o al fallimento.
Lo studio eCREAM, finanziato dalla Commissione Europea, punta a usare l’intelligenza artificiale per analizzare automaticamente le cartelle cliniche compilate nei Pronto Soccorso, trasformandole in dati utili per la ricerca clinica e l’organizzazione dei servizi sanitari. Il sistema utilizza tecniche di Natural Language Processing per interpretare il linguaggio specialistico dei medici e sarà testato per predire i ricoveri e analizzare l’affluenza ospedaliera.
Il progetto I3LUNG, invece, si concentra sull’intelligenza artificiale per il tumore al polmone. Coordinato da sei centri clinici internazionali e guidato in Italia dal Dipartimento di Oncologia Sperimentale del Mario Negri, mira a creare uno strumento decisionale che suggerisca il miglior trattamento per ogni paziente sulla base di dati genetici, clinici, molecolari e psicologici raccolti da oltre 2.000 pazienti.
E ChatGPT? Utile, ma con cautela
Anche ChatGPT è entrato nella discussione sull’intelligenza artificiale in sanità, ma con un ruolo diverso. A differenza degli strumenti clinici veri e propri, ChatGPT non elabora dati strutturati per offrire diagnosi o previsioni, ma è un modello linguistico generativo.
Ciò lo rende utile per semplificare testi medici complessi, riassumere referti o lettere di dimissione e organizzare la documentazione sanitaria in forma chiara e leggibile. È uno strumento potenzialmente prezioso per pazienti, medici, personale amministrativo e studenti. Tuttavia, finché attinge a fonti generiche del web, i suoi contenuti non possono essere considerati affidabili al 100%.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha invitato alla cautela: le IA generative come ChatGPT devono essere valutate con attenzione, affinché non indeboliscano la fiducia negli strumenti clinici validati. L’uso di questi strumenti, dunque, deve essere affiancato da una verifica continua delle fonti, proprio come si fa con le ricerche su Google.
La rivoluzione dell’intelligenza artificiale in medicina non è più un’ipotesi futura, ma una realtà concreta, in grado di salvare vite e ottimizzare risorse. Ma come ogni cambiamento radicale, richiede regole chiare, valutazioni rigorose e formazione adeguata. Solo così l’IA potrà davvero diventare uno strumento sicuro, etico ed efficace al fianco dei medici e dei pazienti.

